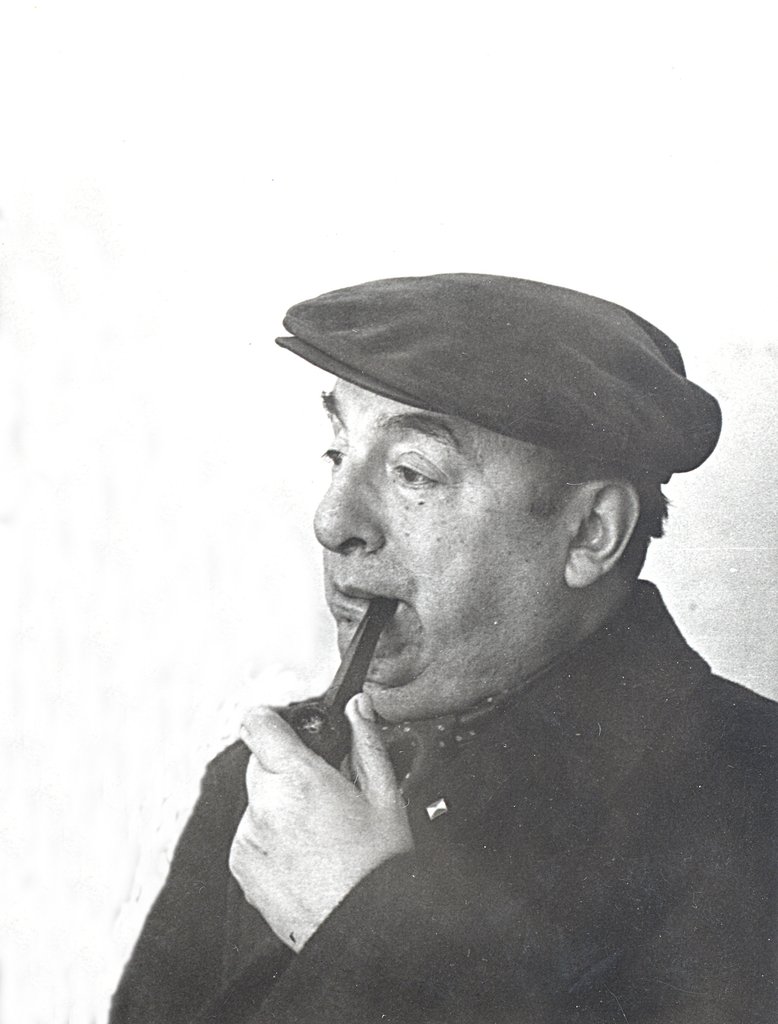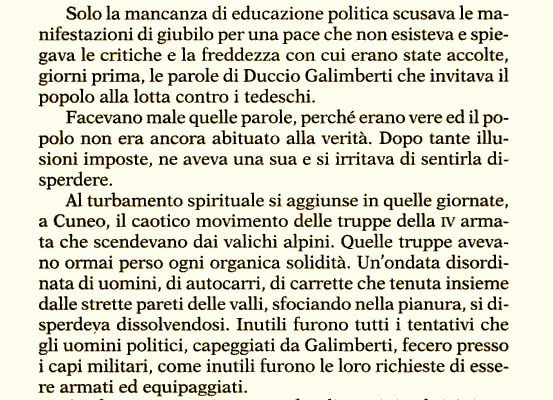Antonio Polito scrive sul Corriere un pezzo interessante, che dovrebbe destare un certo dibattito.
In sostanza il giornalista porta all’attenzione di tutti una riflessione pungente sul rapporto genitori/figli nell’Italia contemporanea; e per farci comprendere come la situazione dei figli non sia poi così scomoda, elenca una serie di pretese, o di diritti, di cui essi possono godere.

Secondo Il Post, Polito assume alcuni toni paternalistici, pur accusando i genitori proprio di paternalismo.
Ora, se paternalismo è l’atteggiamento di un governo, e quindi mutatis mutandis di un genitore, che protegge i propri cittadini/figli e nello stesso tempo non nutre alcune fiducia nella loro autonomia, è per me importante chiedersi non solo, e forse non tanto, come uscirne, se questa domanda prevede un giudizio senza appello sui genitori stessi, quanto il perché si sia diffuso questo atteggiamento medesimo.
Perché se è vero – e lo dico da insegnante e da persona che frequenta le giovani generazioni al di là dello spritz serale – che è sconsolante osservare come molti ragazzi appaiano collocare se stessi in una posizione di attesa passiva della propria realizzazione, quasi che essa debba “capitare” come una ventura, un caso, una combinazione di coincidenze fortunate, è altrettanto vero che – nella logica mediatica – chi tra di essi prova ad affrontare la complessità di questo mondo, sopportandone le contraddizioni, non riceve alcuna visibilità . Non ottiene cioè né riconoscimento economico, né riconoscimento tout court. Lo sguardo sui figli è insomma confinato in due macro-atteggiamenti, per lo più: il giudizio, alla Polito, per cui “dovresti darti da fare e non lamentarti tanto” oppure la super protezione dei «genitori-orsetto», contro cui scrive Polito stesso, che pretendono di salvare la propria prole da questo mondo brutto e cattivo.
Il sottrarsi al confronto con la realtà non dipende solo dalla campana di vetro costruita attorno al pargolo. Dipende nella stessa misura e con la stessa forza dall’invito a darsi da fare, perché esso contiene ugualmente un messaggio svalutativo. Questa sollecitazione si presenta come invito al confronto con i giovani di altri paesi, meno “mammoni” o “bamboccioni” e più pragmatici. E probabilmente questo contiene un elemento di verità . Ma è curioso che non si vadano a considerare, con la stessa intransigenza, le condizioni di vita delle società indicate come più virtuose. E’ interessante per esempio riflettere sul fatto che una legislazione apparentemente più protettiva, come quella che prevede in alcuni paesi nordici la paternità obbligatoria, si accompagni spesso alla presenza di giovani più intraprendenti.
Insomma, ritengo che i termini della questione non siano centrati. Non si tratta di invitare a “proteggere di meno”, perché l’alternativa a questo atteggiamento, e cioè il giudizio, è già presente e ugualmente infeconda. Penso si tratti di accompagnare all’autonomia. Da un lato assicurare una presenza, dall’altro mostrare con la propria esistenza quotidiana che il punto non è non avere problemi, ma saperli affrontare. Una questione di resilienza. E invece l’immagine minacciosa del futuro, dal quale vorremmo proteggere i figli o che invitiamo loro ad affrontare con i denti, è l’immagine della paura degli adulti medesimi. Che però non sanno di ospitare in sé, perché si ritengono forti e soddisfatti, e in diritto di educare gli altri, e non se stessi.

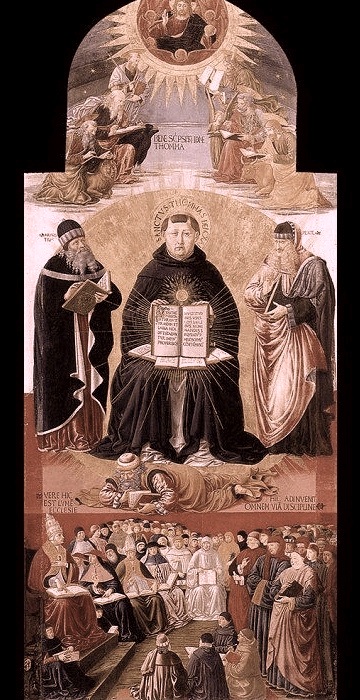
 Tutto continuava come prima, le sentinelle rimanevano al loro posto. camminando su e giù nello spazio prescritto. Gli scrivani copiavano i rapporti facendo scricchiolare le penne e intingendole nel calamaio con il ritmo consueto, ma dal nord stavano arrivando uomini sconosciuti ch’era lecito presumere nemici. Nelle scuderie gli uomini strigliavano le bestie, il camino delle cucine fumava flemmaticamente, tre soldati spazzavano il cortile, ma già incombeva un sentimento acuto e solenne, un’immensa sospensione di animi, come se l’ora grande fosse giunta e nulla più si potesse fermare.
Tutto continuava come prima, le sentinelle rimanevano al loro posto. camminando su e giù nello spazio prescritto. Gli scrivani copiavano i rapporti facendo scricchiolare le penne e intingendole nel calamaio con il ritmo consueto, ma dal nord stavano arrivando uomini sconosciuti ch’era lecito presumere nemici. Nelle scuderie gli uomini strigliavano le bestie, il camino delle cucine fumava flemmaticamente, tre soldati spazzavano il cortile, ma già incombeva un sentimento acuto e solenne, un’immensa sospensione di animi, come se l’ora grande fosse giunta e nulla più si potesse fermare.
 In particolare
In particolare