 Il “programma di ricerca metafisica” costituito dalla psicanalisi – come lo definiva Karl Raimund Popper -, anche e forse ancor più nelle sue versioni (eterodosse e perciò feconde) junghiana e lacaniana, offre senza dubbio la possibilità di leggere le dinamiche del presente, e in special modo le relazioni tra adulti e ragazzi.
Il “programma di ricerca metafisica” costituito dalla psicanalisi – come lo definiva Karl Raimund Popper -, anche e forse ancor più nelle sue versioni (eterodosse e perciò feconde) junghiana e lacaniana, offre senza dubbio la possibilità di leggere le dinamiche del presente, e in special modo le relazioni tra adulti e ragazzi.
Così ne L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento (Einaudi, 2014), Massimo Recalcati potrebbe riuscire davvero a darci alcuni strumenti per interpretare parte di quello che avviene, o non avviene ma dovrebbe, nelle classi scolastiche di oggi. La tesi è subito chiara (p. 5): la funzione dell’insegnante è insostituibile. Eppure va ripensata, perché è cambiato il mondo fuori dalle pareti della Scuola, ad opera, soprattutto, di un attore invadente e inarrestabile: il mercato. La logica neoliberista, il capitalismo attuale, produce risposte ai bisogni e, se non ne trova, ne crea di sempre nuovi. Concretizzare questo meccanismo richiede velocità e competenza: si tratta di saper cogliere ciò di cui ora (non dopo, o domani) c’è richiesta e predisporre la soluzione da vendere, la comunicazione per convincere di questa opportunità , la logistica per farla arrivare “a casa”.
Secondo Recalcati, che si richiama a Pasolini, il trionfo della società dei consumi ha generato una «pedagogia neoliberale che riduce la Scuola ad un’azienda che mira a produrre competenze efficienti adeguate al proprio sistema» (p. 12). La priorità data alla performance cognitiva emargina tutto ciò che è deviante, divergente, critico, alternativo, zoppicante… Elementi invece necessari in ogni autentico processo di formazione.
Questa critica, di principio condivisibile, intende colpire quel che la Scuola dovrebbe diventare (scuola-azienda con prèsidi-manager; valutazioni standardizzate; diffusione dell’iper-tecnologia) oppure si rivolge a quel che la Scuola per certi aspetti è già nella misura in cui la centralità della prestazione ben si comprende nell’ambito della «collusione tra il narcisismo dei figli e quello dei genitori» (p. 25)? Forse l’alternativa è falsa, per certi versi, e si tratta di due aspetti del medesimo fenomeno. Il trionfo dell’io della/nella Generation-Me, figlia della liberazione 68/77ina (o di un suo esito), si fonda insieme sulla estrema competenza nel focalizzare i desideri e sull’abilità nel rendere il percorso per esaudirli quanto più lineare possibile. E’ la Scuola-Narciso (pp. 24 e sgg.), che, dopo le barricate della Contestazione, ha preso il posto della versione edipica dell’istituzione formativa (pp. 20 e sgg.).
 Non diversamente, Laura Pigozzi, in Mio figlio mi adora (Nottetempo, 2016), sulla scia di Hegel letto da Lacan: «ogni sapere che si vuole tenere al riparo dal coinvolgimento e, quindi, da eros e pathos, è morto, vuoto. Il sapere che conta è quello che è costato la pelle, non quello della prestazione, dell’informazione, dei tecnicismi o dell’obbedienza, ma il sapere legato al rischio, commesso alla passione, che contrasta l’apatia e va in un’altra direzione rispetto all’anestesia contemporanea» (p. 43). Solo il ritiro dei genitori di fronte al percorso dei figli adolescenti (ma anche bambini) può aprire lo spazio necessario di una separazione che sia generativa in senso pieno, quello per cui la creatura è “messa al mondo” e non messa in casa.
Non diversamente, Laura Pigozzi, in Mio figlio mi adora (Nottetempo, 2016), sulla scia di Hegel letto da Lacan: «ogni sapere che si vuole tenere al riparo dal coinvolgimento e, quindi, da eros e pathos, è morto, vuoto. Il sapere che conta è quello che è costato la pelle, non quello della prestazione, dell’informazione, dei tecnicismi o dell’obbedienza, ma il sapere legato al rischio, commesso alla passione, che contrasta l’apatia e va in un’altra direzione rispetto all’anestesia contemporanea» (p. 43). Solo il ritiro dei genitori di fronte al percorso dei figli adolescenti (ma anche bambini) può aprire lo spazio necessario di una separazione che sia generativa in senso pieno, quello per cui la creatura è “messa al mondo” e non messa in casa.
Già – si potrebbe dire, andando oltre questi saggi – ma non tutti i genitori sono disposti a far carte false per spianare la strada ai figli. Ve ne sono di esigenti, sia con loro che con la scuola.
Qui la richiesta performante pare allearsi a quella protettiva di “scuole come una volta”- specie in gruppi sociali benestanti e preoccupati – , e così incrociare e cibarsi fatalmente della tendenza conservatrice (per questioni di età, ma anche di autodifesa) di una parte del corpo insegnante, specie nel sistema dei licei. Creando la curiosa situazione di dirigenti disposti a comprendere (per forza di cose) le istanze di una certa parte dei genitori (narcisi e/o iperprotettivi, o solo in crisi) ma forse in aperto conflitto con porzioni del proprio corpo docente; oppure di docenti che, ripetendo modalità adottate da loro stessi decenni fa o mutuate dai propri insegnanti, si attestano su una frontalità che non è di per sé inefficace (almeno secondo studi di Evidence-based education, per es. QUI), ma che potrebbe non lasciar alcuno spazio al momento di rielaborazione e costruzione condivisa del sapere.
E così, rischiando di dividere i collegi docenti tra presunti docenti-colomba, che in realtà si pongono il problema non di spiegare il mondo, ma di capirlo insieme alla classe e presunti docenti-falco che invocano un maggior rigore (una narrazione riesplosa dopo la fase di restrizione pandemica).
Per i secondi, Dirigenti e Ministero (specie quello della nefanda Buona Scuola) rappresenterebbero quindi fenomeni di “corruzione” della sana istruzione, ormai mercificata e ridotta a test Invalsi, di contro alla maggioranza degli insegnanti (parlo dei segmenti superiori), arroccati sull’aventino. Sono essi davvero la parte più numerosa? Non si sa, ma non solo in occasione delle proteste contro i tentativi ministeriali, molti di costoro impiegano una retorica della minoranza in piena azione resistenziale. Nello stesso tempo, un insegnante o una insegnante che chiede molto rassicura una parte di genitori e insieme li preoccupa, quando vedono la prole «star su fino all’una di notte” (e la prole stessa si sente però ingaggiata) o raccontar loro dei compagni e compagne di classe che si ritirano da scuola (o il darwinismo scolastico è banco di prova del valore di mia figlia, mio figlio?).
Decenni di sacrosanta psicologia dell’apprendimento, dell’età evolutiva, dell’adolescenza sono però arrivati a informare il linguaggio anche di ragazze e ragazzi, che da oggetto non identificato osservato nel microscopio degli adulti, stanno diventando anche soggetto del proprio percorso educativo-formativo. Potrebbero, al rimbrotto, non rispondere più con un grugnito, chiudendosi alle spalle la porta della cameretta, ma rispondere a tono «che cosa vuoi da me, sono un adolescente!». Il meccanismo della ricompensa, struttura fondamentale dei social non è più un ladro che agisce nell’ombra: ragazze e ragazzi lo conoscono, e non ci fanno caso, prendendo semplicemente atto che non trovano alcuno stimolo a stare di fronte ad un’ i n t e r a pagina di manuale. Il mercato dunque suggerisce video, brevi se possibile (ma nell’ansia preverifica anche una ventina di minuti è accettabile) che ti spiegano le leggi di Keplero o l’eterno ritorno di Nietzsche. La scuola tenta di rispondere con strategie come la flipper-classroom – ottima iniziativa. Ma poi, abbiamo gli strumenti (le griglie per es.) per valutare un dibattito in classe? Se il docente-colomba costruisce un modulo sulla base di un lavoro di gruppo, come potrà valutare la percentuale certa (minima spesso) di alunn* che, indaffarati a recuperare l’altra disciplina, o semplicemente underachiever, lasciano il lavoro a* compagn*? Perché, per gli e le altr*, il voto di un tal lavoro dovrebbe valere al 30, 50, 70 percento, di contro alla classica prova orale o scritta?
Il limite di tutto questo pippone è semplice: i docenti, le docenti, non hanno tempo (voglia?) di aprire uno spazio di riflessione tra loro o con la componente studentesca e genitoriale. O meglio, potrebbe anche accadere (raccontatemelo), ma non è certo prassi comune. E, poiché, in ogni caso, cascasse il mondo, si deve arrivare al numero congruo di valutazioni, che a scuola significa voti numerici (cosa per nulla ovvia), la macchina procede imperterrita. Ragazze e ragazzi (i bambini non ancora) ci osservano e spesso accettano, un po’ perché “si è sempre fatto così” (e la cosa rassicura), un po’ perché sono avvezzi a gente-adulta-che-spiega-loro-cose. AH! Vuoi vedere che – o tempora o mores – gli adulti non hanno più nemmeno il diritto di spiegare le cose? E se fosse proprio questo, il cambio di paradigma?


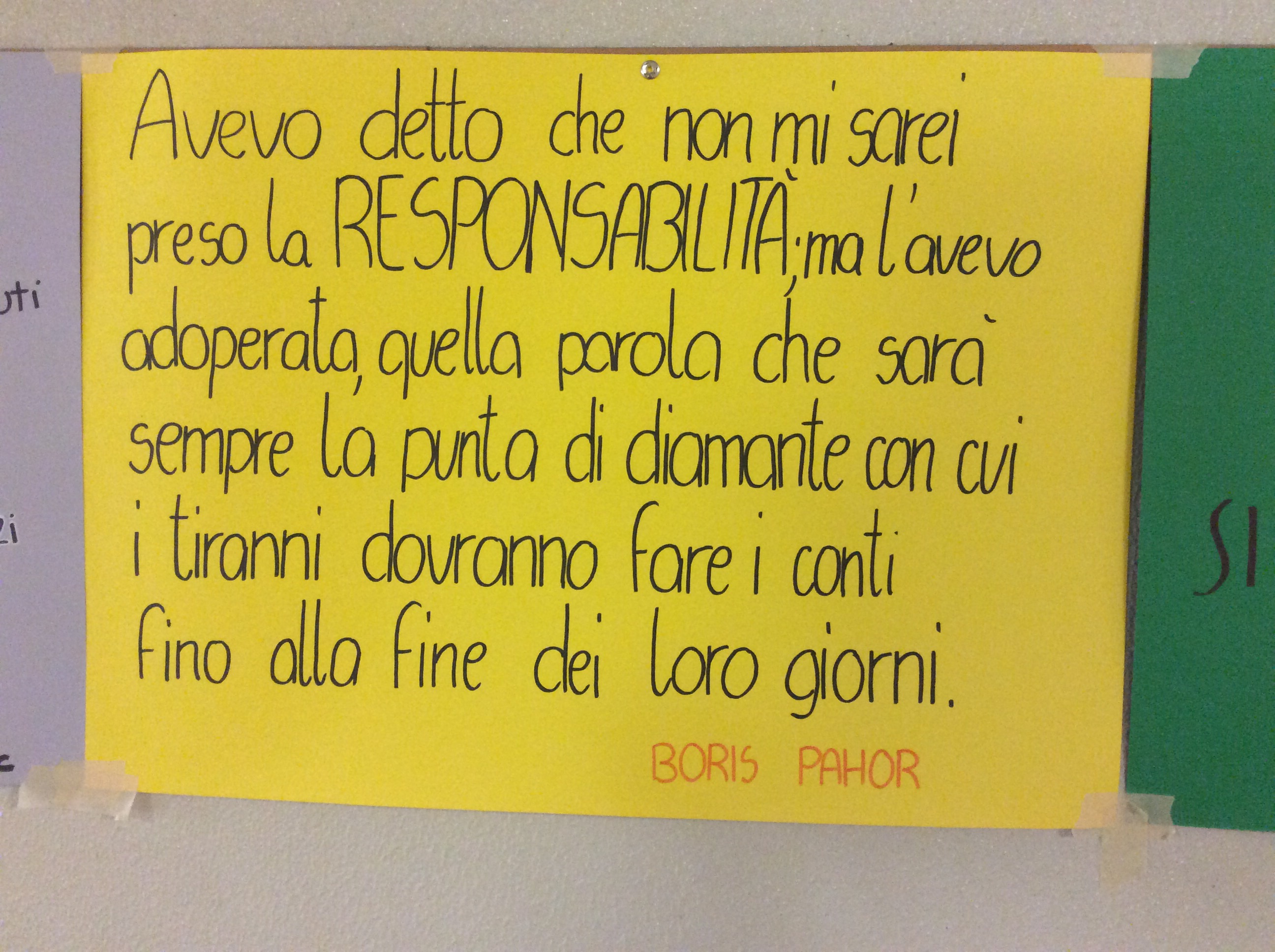

 Il divertissement di Christian Raimo (
Il divertissement di Christian Raimo ( ento sia addebitabile agli studenti.
ento sia addebitabile agli studenti.