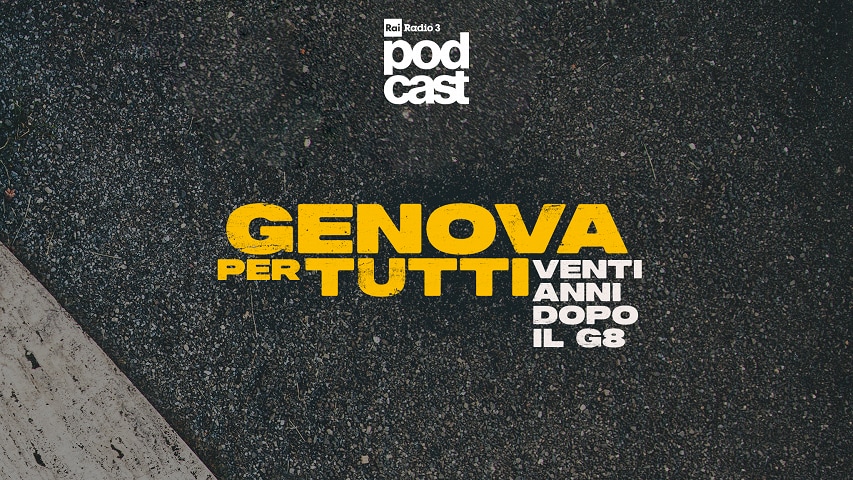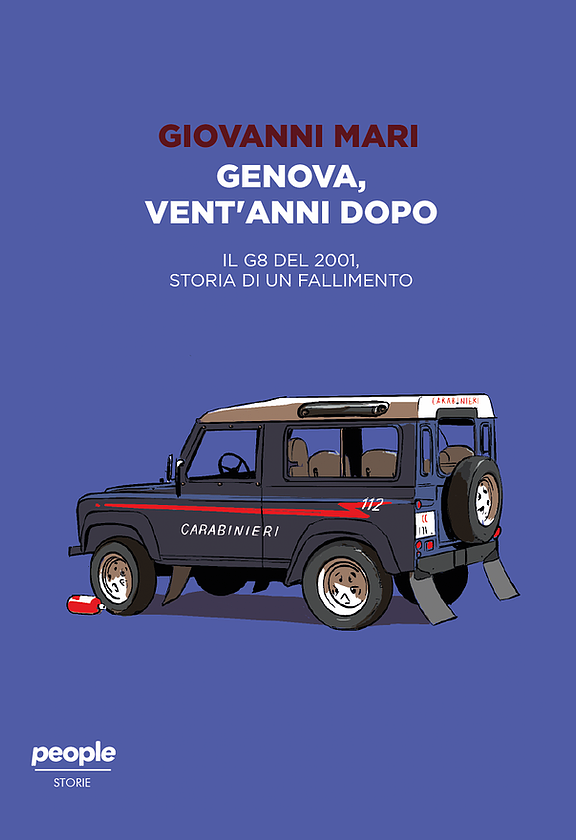(Editoriale per Madrugada – giugno 2024)
Tante di voi avranno osservato bambini giocare. E’ una possibilità che capita a molte persone e tuttavia è meno ovvia di quel che appare, e non solo perché ci sono meno creature in giro. Lo è perché adottare una posizione di pura contemplazione, dall’esterno, di un gioco infantile, prevede per un qualche lasso di tempo la sospensione delle azioni di cura. Questo astenersi mi pare difficile, in questi tempi di iper-attenzione spesso ansiosa.
Eppure accade, e quando accade ci si può render facilmente conto almeno di due cose: che buona parte del gioco, per loro, consiste nella preparazione, nell’allestimento del gioco stesso, del suo setting, delle sue regole; che, una volta adottate le parti nel gioco, una volta iniziato il gioco delle parti, per la bambina o il bambino non c’è distinzione tra reale e virtuale. O meglio, è tutto vividamente reale.
Se è vero che lo spirito critico di Macondo aveva anni fa rilanciato l’esigenza di restituire spazio all’infanzia (ricordate “I bambini torneranno a giocare” e lo sguardo di Giuseppe per i bambini stessi?), è altrettanto vero che – nel frattempo – il capitalismo ha superato a destra la nostra sollecitudine, facendo diventare l’infanzia una prodigiosa occasione di mercato. Nella sua diabolica capacità di permeare ogni aspetto dell’esistenza, il capitale ha ingurgitato anche la predisposizione alla cura, costruendo nel contempo condizioni efferate di miopia: i bambini di Gaza non esistono, se non per qualche reel strappa-click.
Laggiù in condizioni non immaginabili, come anche dalle nostre placide parti, i bambini e le bambine continuano a giocare. Come ebbe a scrivere Pessoa: un bambino sa che la logica e il significato/ sono solo un nulla che nulla nasconde, /e un bambino ha la divina consapevolezza /che tutto è un giocattolo e tutto è bello, / un ditale, una pietra e un rocchetto di cotone / sono cose che possiamo sentire perfettamente, / e se ne facciamo degli uomini, /essi sono uomini reali, non fantasie.
Facevamo che eravamo
Ogni gioco, non solo sportivo, ha le sue regole. Sono i limiti e le possibilità che si contrattano, con se stessi o con gli altri partecipanti, nel tempo dedicato. Alcune sono stabilite a priori (non è necessario spiegare prima di ogni partitella cosa faccia il portiere, né quale siano le operazioni da compiere per muovere il personaggio di pixel sul piccolo schermo), per le altre c’è la creatività del momento. Fingersi venditori in un negozio allestito in salotto, principi e draghi, ladri o spie, costruire una tenda con vecchie lenzuola, ombrelli e tappetini, inventare un assist oppure un’astuta finta, o ancora capire come muoversi in un ambiente nuovo di Minecraft sono dimensioni tutto sommato simili. La presenza di determinate possibilità e di altrettanti limiti fa sì che, in situazione di gioco, si assuma una precisa identità: quel che io sono aderisce perfettamente alle condizioni in atto.
Poi l’allenamento termina, l’arbitro dichiara la fine del match, arriva l’ora della merenda o dei compiti – oppure solo si cambia gioco. Più o meno docilmente si esce da quella identità per sperimentarne di diverse, tenendo però come sfondo irrinunciabile tutti gli altri aspetti necessari della vita. Diciamo, della realtà.
Se all’interno del gioco posso aver acquisito le capacità e il potere di realizzarmi (vincere la partita, divertirmi), fuori le esigenze del mondo costringono a rinunciare ad avere sempre la meglio. Se un qualche tipo di pensiero “magico” persiste, se per esempio arrivo tardi al lavoro perché non posso non calpestare tutte le fughe che dividono le mattonelle del marciapiede, verrò invitato prima o poi a prendere atto di una qualche forma di nevrosi. Se l’identità come giocatore seriale tracima dagli spazi ben definiti e diventa senso di intere giornate, si parla di ludopatia. Se, infine, so stare dentro e fuori dal gioco – e posso farlo anche interpretando le incombenze quotidiane come un qualche tipo di gioco, attraversandone così diversi – possiedo al contrario la capacità di distinguere identità e appartenenza. La seconda apre, la prima chiude.
A chi appartengo?
Potrei avvertire come urgente il rigore della meditazione, cercando di realizzarla, ispirato da un maestro zen; potrei continuare a praticare la vita di una comunità cattolica, apprezzandone la potenza dei simboli liturgici, se ben eseguiti, come la potenzialità delle sue iniziative sociali; potrei adottare uno stile di alimentazione quanto meno carnivoro possibile, pur con la nostalgia di grandi abbuffate bovine; potrei apprezzare alcune partite di calcio e insieme cercare di approfondire lo sport del rugby, senza disdegnare i set di pallavolo; potrei restare affascinato dall’eleganza della cultura giapponese e ascoltare il folk irlandese; potrei donare del tempo alle Variazioni Goldberg di Bach, suonate da Gould, e non cambiare stazione radio se inciampo in un notevole pezzo dei Led Zeppelin; potrei pormi, ogni mattina, il problema di non ignorare le ingiustizie sostanziali che persistono vicino e lontano da me, senza abbandonarmi alla narrazione per cui tutto sta andando verso il peggio. Potrei insomma appartenere a tante cose, senza far di nessuna di esse la-mia-identità. Potrei giocare su tanti tavoli, senza diventare dipendente.
Mi viene in mente un brano dell’antropologo Ralph Linton, citato da Marco Aime (Eccessi di culture, 2001), di cui riporto solo la conclusione, che ne conserva lo spirito: «Quando il nostro amico ha finito di mangiare, si appoggia alla spalliera delle sedie e fuma, secondo un’abitudine degli indiani d’America, consumando la pianta addomesticata in Brasile o
fumando la pipa, derivata dagli indiani della Virginia o la sigaretta, derivata dal Messico. Può anche fumare un sigaro, trasmessoci dalle Antille, attraverso la Spagna. Mentre fuma legge le notizie del giorno, stampate in un carattere inventato dagli antichi semiti, su di un materiale inventato in Cina e secondo un procedimento inventato in Germania. Mentre legge i resoconti dei problemi che si agitano all’estero, se è un buon cittadino conservatore, con un linguaggio indo-europeo, ringrazierà una divinità ebraica di averlo fatto al cento per cento americano». Si prega di maneggiare con cura le identità.
Un bel gioco dura poco
Stare dentro e poi fuori dal gioco, per poterne giocare altri, ma in modo mai conclusivo – coltivare le proprie molteplici appartenenze – significa in fin dei conti tollerare il limite fondamentale del game stesso, cioè la possibilità di perdere, di essere sconfitti. Bambine e bambini lo sanno bene, per quanto poi si arrabbino e ci facciano capire la loro delusione: il giorno dopo ricominceranno con gli stessi giochi. Solo quando, un poco più grandi, con l’adolescenza entreranno nella sfida di definire se stesse e se stessi – costruire la propria identità – i giochi si faranno duri, per sé e chi li circonda. La lenta rabbiosa operazione di capire chi si è, chi si desideri essere, chi ci tocchi essere, sembra davvero difficile da prendere come un gioco: ora il come sono passa attraverso il come vengo visto, corpo capelli abbigliamento assumono importanza, il giudizio altrui viene soppesato di sottecchi e poi, sembra, ostentatamente ignorato – ma anche questo è un gioco.
Quando albeggia una certezza, essa diviene capitale (uno sport, la squadra del cuore, il gruppo di amici, una passione – anche scolastica, un amore, una chitarra elettrica).
Dovremmo permetter loro di stare in questa creativa confusione e invece – forse perché, come prof, sono parecchio concentrato su di loro – spesso penso che alcuni tratti della società in cui siamo non siano maturi, ma a loro volta adolescenziali. C’è lo scetticismo di non accettare per buona alcuna verità, o anche solo la realtà delle cose, e insieme l’esigenza continua di costruire conferme alla propria identità. Alcune personalità della politica e dell’economia non hanno in fondo atteggiamenti da super-adolescenti? Le scarpe e i cappellini, nonché l’ottusa autoreferenzialità, dell’Americano; la sicumera anabolizzata dell’Esploratore auto-spaziale; l’offesa prosopopea del Padano; la ridanciana aggressività della Romana. Se smettono di giocare rischiano di perdere molto. E non accade solo perché loro sono personaggi pubblici costruiti (dalla vita e dai propri social media manager). Fate questo gioco: fermatevi a guardare le persone adulte con cui dovete confrontarvi e provate a cogliere prima il bambino, la bambina che è in loro, e poi l’adolescente che le abita – le molteplici appartenenze e il disperato sforzo di essere qualcosa.
A cosa giochiamo?
Tra il momento in cui scrivo e quello in cui leggete accadranno le elezioni europee. Quale sarà l’alternativa? Tra una destra radicale e una destra liberale? PPE e Socialdemocratici incasseranno il colpo o lo subiranno? Prevarrà la nostalgia per i princìpi originari dell’UE o per le soluzioni di forza? Avremo tutto il tempo di esser nauseati dal fiume mediatico dei commenti. Per ora, desidero condividere il criterio che vorrei adottare: nei proclami e nei programmi, cercherò parole che mi suggeriscano cose reali (la famiglia in trasformazione, le migrazioni come dato di fatto umano, la paga oraria delle giovani lavoratrici e dei giovani lavoratori, il denaro effettivamente investito nella salute e nella scuola, gli ambiti di ricerca alimentare o tecnologica in espansione etc.). Mi guarderò invece da chi, parlandomi di fantasie, tornerà ossessivamente sull’unica cosa che fa ben finta di avere: cristiana, occidentale, eterosessuale, bianca – una qualsiasi identità.