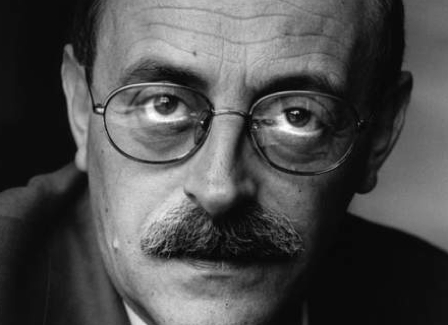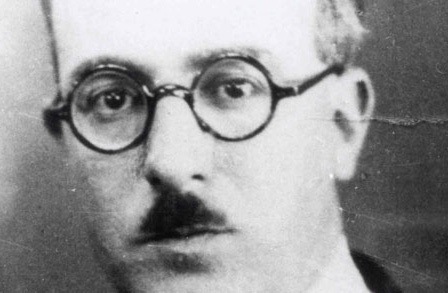Sul “Corriere della Sera” del 18 febbraio scorso, Guido Ceronetti scrive un articolo denso, che si rivela provocatorio solo per chi avesse il tempo di intenderlo. Gioca infatti interamente sul binomio pazienza/comprensione del mondo, anche se titolo (Un servizio civile come antidoto alla brama del posto) e sottotitolo (I guai della disoccupazione mentale) parrebbero andare in altra direzione.
La proposta di Ceronetti non è nuova, ma raramente – mi pare – è stata presa sul serio: istituire un servizio civile obbliglatorio per maschi e femmine, italiani d’origine o acquisiti, da svolgersi tra i 18 e i 20 anni.
“Voglio accennare al mai disoccupato problema della disoccupazione giovanile, stufo di sentirne trattare con adulazione oscurante e retoricaccia di finta compassione, lontano da ogni buon senso. Perché questo ho veduto. La fine della dannatissima naja (il servizio militare costituzionalmente obbligatorio) ha nociuto ai giovani maschi italiani. L’esercito ridotto e a base volontaria era la soluzione più giusta e razionale: ma tra i diciotto e i venti anni per innumerevoli altri si è aperto uno sbadiglio di noia, frustrazione, poltroneria, caccia nevrotica del posto sfruttata per fini di potere da falsi amici avidi di consenso facile, di voto futuro. La mia proposta di utopistico bene sociale è di istituire un servizio civile ovviamente disarmato per tutti i giovani, uomini e donne di diciotto-diciannove e vent’ anni, della durata di un anno e mezzo, fatto di servizi utili alla collettività , apprendimento di mestieri, studio, giochi, sport, teatro, pronto impiego nelle calamità . I figli degli immigrati con cittadinanza italiana ne farebbero parte alla pari e insieme con tutti gli altri”.
Non so se nelle cose accade davvero che ci si lanci, terminata la secondaria di secondo grado, alla ricerca del posto. Temo che un certo numero di ragazzi intercetti piuttosto le altre possibilità evocate: noia, frustrazione, poltroneria. Confezionate talvolta con l’abito rispettabile di un corso universitario.
Ma la statistica non è il cuore della questione. Quel che Ceronetti evoca è la deificazione del “mercato del lavoro”, quale unico orizzonte di senso possibile. Certo: lavorare bisogna, e persino lavorare è bello, ancorché stanchi. Ma la logica del mercato applicata a tutto (lo spot della “MasterCard” sembra innocuo, ma rivela la potenza che il denaro possiede di divenire metro di giudizio del cosmo), svuota il significato del lavoro come veicolo di creatività trasformativa della terra, perché il lavoro diviene mezzo per il denaro, cioè per l’acquisto, e quindi la risoluzione di bisogni (più o meno indotti).
Ceronetti, correttamente – ma ben lungi dall’accarezzare il cosiddetto politically correct, elegante maniera per dire che rinunciamo a scannarci dicendo come le cose stanno perché gli interessi comuni alle due parti sono più invitanti – denuncia sin dalle prime righe il posto che si è preso e che non gli verrà tolto,
“l’idea che, lavorando nella parola, piegando a dare musica il ferro del verbo poetico, dispiegando ai crocicchi e sulle piazze filosofia etica, fumata fino all’intossicazione con la pipa del povero giudeo portoghese Baruch Spinoza – si potrebbe produrre il miracolo di una particella minima di bene sociale, in cui fermentassero germi di salvezza universale”.
Delinea da subito il manifesto dell’inutilità , proprio di poesia e filosofia. O meglio, dell’apparente inservibilità , in quanto incommerciabilità , di esse. Espulse loro, come Spinoza dalle chiese-sinagoghe-congregazioni di mezz’Europa, però, espelleremo anche la sana capacità di attendere, lavoro o amore non importa, la possbilità di non divorare il mondo, e quindi noi stessi, gli uni gli altri.
Ecco che l’azione civile di un servizio annuale dedicato ad altri avrebbe la funzione di antidoto alla corsa insensata: una sorta di poesia delle mani, di filosofia delle relazioni, per imparare ad aspettare.
(QUI, l’articolo completo)
 “Ieri sera qui a Genova è morto don Piero Tubino,
“Ieri sera qui a Genova è morto don Piero Tubino,