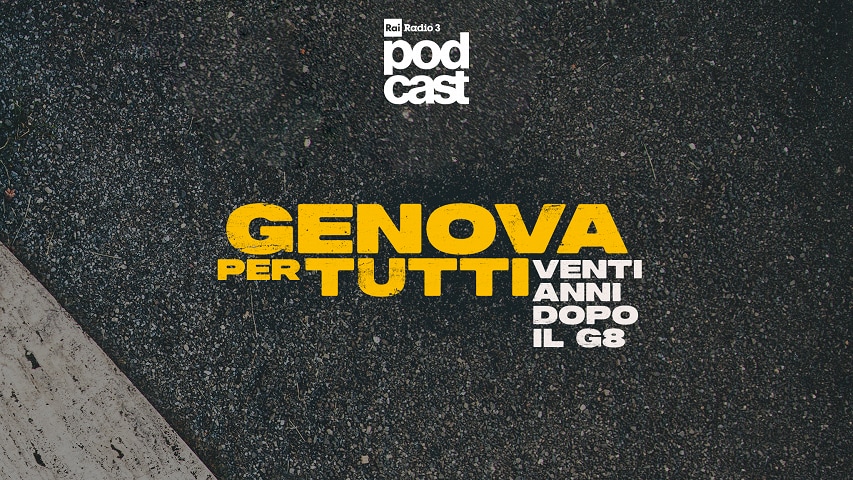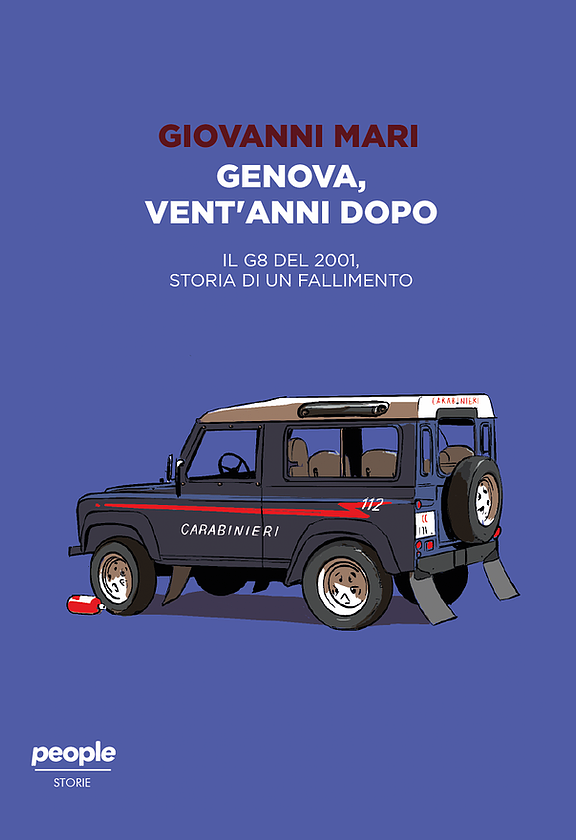L’amministrazione comunale di Este mi ha chiesto di tenere l’orazione per il Giorno della Liberazione. Questo il testo.
Ho di cuore, e con una certa emozione, accettato l’invito della dottoressa Businarolo, nonostante i tempi stretti, dovuti alla malattia del prof. Angelini, che ringrazio da lontano per il suo impegno nell’ANPI.
Lo scopo di questo discorso è quello di commemorare, cioè di riportare alla memoria. Cum – memorare: rimettere al centro i fatti degni di essere ricordati. Questo è un primo senso della Festa odierna. Ma cum – memorare può essere inteso come il radunare coloro che sono memori, coloro che non dimenticano. Qui ci troviamo perché intendiamo ricordare.
Ecco, la prima fatica è proprio questa: non separare i fatti da ricordare da coloro che si sforzano di riportarli alla memoria. E’ legittima infatti la domanda, che immagino possa essere formulata da una delle ragazze o dei ragazzi che incontro a scuola, nelle ore di storia: ma tu, perché vuoi ricordare questi fatti?
Ma tu, perché vuoi ricordarCI questi fatti?
Se dimentichiamo questa domanda, quei fatti diventano dei fossili. Segni di una vita che non c’è più. Se dimentichiamo questa domanda, i morti vengono sepolti di nuovo, i sopravvissuti sono ridotti a monumento. Se dimentichiamo questa domanda, il motivo per cui essi sono morti, il motivo per cui hanno combattuto – anche se scolpiti nel marmo delle nostre lapidi – vengono ridotti a una delle tante scelte individuali, che in quanti tali, appaiono tutte uguali.
Se dimentichiamo questa domanda, facciamo
della nostra scelta di ricordare
una pratica di retorica.
Permettetemi allora di rifare questa domanda, a partire dalle parole di uno scrittore che si è posto la questione di una narrazione antiretorica della Resistenza e della Guerra civile
Luigi Meneghello,
parole di cui tra qualche giorno potrete godere appieno, nell’iniziativa che la Città di Este ha previsto per il 30 aprile.
Luigi Meneghello, di cui ricordiamo i cento anni dalla nascita.
In Fiori italiani leggiamo
S. sapeva che c’erano “antifascisti”, da tempo ne frequentava uno, una persona che ammirava e da cui era vivamente attratto. Stranamente invece (sembrano cose assurde, ma è la verità) non aveva pensato in modo esplicito che ci fossero dei “fascisti”, separabili dagli altri italiani, salvo in contesti banali, per esempio i professori di ginnastica, o i federali. Si affacciava un pensiero semplice e sconvolgente: S. non sapeva ancora che cosa fosse, ma sentiva con un misto di umiliazione e di paura che stava per saperlo.
Qual è questo PENSIERO SCONVOLGENTE che si affaccia alla mente e al cuore di questo giovane universitario?
Lo leggiamo poco dopo:
Devo ora parlare dell’uomo che fu il maestri di S., mio, e dei nostri compagni, Antonio Giuriolo. L’incontro con lui ci è sempre parso la cosa più importante che ci sia capitata nella vita: fu la svolta decisiva della nostra storia personale, e inoltre (con un drammatico effetto di rovesciamento) la conclusione della nostra educazione.
Poiché non è sopravvissuto alla guerra (morì a 32 anni, nel dicembre 1944) è naturale che la sua figura sia restata per noi nella luce in cui la vedemmo allora: credevamo di avere incontrato una personalità straordinaria animata da forze miracolose.
Oggi si potrebbe pensare che questo fosse soltanto un riflesso nei nostri occhi: effetto dello shock di avere incontrato un uomo che davvero non aveva ceduto al fascismo.
Lo shock di incontrare un uomo che davvero non aveva ceduto al fascismo.
Il riferimento non è a chi, come per esempio Gobetti, o i fratelli Rosselli, nati tra il 1899 e il 1901, comprendono già nei primi anni Venti quale fosse la direzione presa dall’Italia.
Meneghello, nato nel ’22, l’anno prima della Riforma Gentile della scuola, cresce come fascista: per lui, per la sua generazione, la medesima di Beppe Fenoglio o ancora di Claudio Pavone e di David Maria Turoldo poco più vecchi, il fascismo non è una opzione, è la normalità. E’ l’acqua in cui nuotano i pesci, che di essa nulla sanno, perché sono lì da sempre.
Scrive Meneghello (p. 28)
Quanto al fascismo, la scuola elementare risultava efficace: ciò che c’era da imparare s’imparava in modo definitivo, e non occorreva più tornarci sopra per tutto l’arco degli studi successivi.
e ancora (p. 31), parlando dell’Italia
il fascismo non è al centro: è dappertutto. Il ricordo della lotta ai sovversivi è distanziato, ora sembrano scomparsi (…); da qualunque parte la si guardi, la vita italiana appare fascistizzata senza residui.
Vi è più curiosità che rammarico, in queste parole di Meneghello.
Senza dubbio il fascismo agì come un potere coercitivo, con continuità e poi sistematicità. Ma – a spanne – tra il ’25 e la guerra, agisce nel fascismo anche un’altra forma di potere, ben più efficace, la capacità di PLASMARE IL FUTURO DELLE PERSONE, di prendere il posto nell’anima delle persone, di dar loro l’illusione avere un senso, una qualche collocazione.
«Lo studio dei regimi totalitari
dice lo storico Paul Corner,
suggerisce che violenza/repressione e partecipazione/consenso sono due facce della stessa medaglia (…) La maggior parte della gente probabilmente si trovava a metà: consapevole della brutalità fascista ma anche sensibile ai cambiamenti che il fascismo stava operando (…); non sposò necessariamente le politiche dittatoriali ed espansionistiche, ma era consapevole delle opportunità in termini di benefici personali e per la famiglia. E soprattutto sapeva di non aver scelta: i fascisti controllavano tutto (tranne la Chiesa) e l’accesso a lavoro, pensioni, assistenza sanitaria, permessi, licenze e così via dipendeva dal non contrastare il regime»
e Geraldine Schwarz, nel saggio I senza memoria. Storia di una famiglia europea
I genitori di mio padre non erano stati né dalla parte delle vittime né da quella dei carnefici. Non si erano segnalati per atti di coraggio, ma non avevano neanche peccato per eccesso di zelo. Erano semplicemente Mitläufer, persone “che seguono la corrente”, conformisti, gregari. Semplicemente: nel senso che il loro atteggiamento era stato quello della maggioranza del popolo tedesco, un accumulo di piccole cecità e piccole viltà che, messe l’una accanto all’altra, avevano creato le condizioni necessarie al compiersi di uno dei peggiori crimini di Stato organizzati che l’umanità abbia conosciuto.
Che cosa era accaduto?
Il potere del regime è stato quello di prendere le organizzazioni, specie giovanili, ma non solo, organizzazioni che avevano avuto un ruolo di unificazione sociale e di averle rese perverse, oppure di crearne altrettante, artificiali e egualmente perverse.
Là dove la perversione non era entrata,
pensiamo ai gruppi clandestini, ai gruppi in carcere o al confino (Il manifesto di Ventotene), pensiamo all’esperienza bellica in Russia di Nuto Revelli, ma anche agli insegnanti sospesi per motivi politici o a molti gruppi cattolici – per esempio parte della Fuci di Aldo Moro – o ancora alla cerchia di persone che gravitava attorno ad Aldo Capitini a Pisa –
in questi contesti era stato conservato lo spazio, direi l’energia mentale e spirituale, per una visione diversa della realtà.
Almeno due sono gli elementi che accomunano questo spazio:
da un lato, l’incontro personale, come quello descritto da Meneghello, con una persona non domata, non gregaria
Giuriolo per Meneghello, Piero Chiodi per Fenoglio, Eugenio Colorni o Nestore Tursi per Pavone, Eugenio Curiel per Turoldo e De Piaz.
Sono solo alcuni.
Ancora Meneghello
Un modo nuovo per fare i vasi ha una sua potenza educativa immediata; ma se si tratta di invece di fare gli uomini, la mente degli uomini e delle donne, non c’è forse altro modo che quello antico, paziente, difficile di esemplarli su modelli viventi. Un metodo che non si può importare, né copiare.
L’influenza di Antonio veniva dal profondo dell’uomo, era essenzialmente un esempio.
Dall’altro lato il percepire nella carne e nel sangue una tensione alla libertà, che diventa imperativo, dovere interiore
La libertà di Antonio era il nome della sola ispirazione religiosa che gli pareva possibile per dei laici (p. 168)
E’ la stessa capacità di dire di NO che abita Piero Chiodi quando decide di reagire, o meglio ancora di agire altrimenti (da Banditi)
Una ventina di militi (della Repubblica Sociale Italiana, ndr) caricavano su un camion quattro giovani legati mani e piedi. Ho sentito uno gridare: – No, sono innocente! – Un’ora dopo ho rivisto i militi che cantavano in un caffé. Si è sparsa fulminea la notizia che i quattro giovani sono stati massacrati al Mussotto sul luogo in cui, giorni fa, era stata uccisa una SS.
Non posso trattenermi dall’infilare la bicicletta e recarmi al Mussotto. A cento metri dalla cantoniera, sul bordo della strada, una gran pozza di sangue. Un vecchio cantoniere mi descrive, piangendo come un bambino, la orribile scena. Allontanandosi dice: – E’ meglio morire che sopportare tutto questo.
“Meglio morire” per Piero significa: piuttosto sfidare la morte
perché
e torno a Meneghello
Una vita individuale, una società hanno senso in quanto si fondano su questa libertà: opporla a qualunque altra ispirazione morale e politica della comunità non è solo sviante, è mostruoso. Senza di essa non c’è alcuna società (come non c’è alcuna vita privata) che valga la pena di vivere.
Questa libertà, che si concretizza nella Liberazione,
non è UN valore tra tanti valori
è piuttosto un PRINCIPIO
cioè apre una direzione,
nelle parole di Pavone (Una guerra civile)
La ricostruzione di un più profondo sistema di umana solidarietà
o in quelle della non-violenza di Capitini
prendere le distanze da una civiltà che valuta positivamente soltanto chi fa, chi rende, chi è forte, chi è attivo
Non si è trattato di andare solo contro il fascismo, ma anche contro le condizioni che lo hanno permesso.
Non si tratta solo di rifiutare il fascismo, ma di comprendere in che modo esso si ripresenti, come dice Umberto Eco, in abiti civili, o con Foucault, nelle minute forme che fanno l’amara tirannia delle nostre vite quotidiane.
Questa potrebbe essere una riposta valida alla domanda che ci siamo posti all’inizio:
perché ricordare questi fatti?
Perché il compito di ricostruire un più profondo sistema di umana solidarietà non si è ancora concluso.
Grazie.