La terra straniera dalla quale parte Michela Murgia, in questo denso Futuro interiore (Einaudi, 2016), non è la pur maltrattata Sardegna, le cui brulle terre e meravigliose acque fanno da sfondo costante, non detto. È la sua età anagrafica, che le permette un carotaggio sui quaranta-cinquantenni. Ma quasi a scardinare il teorema della sua coetanea Jean Twenge (Generation Me), secondo cui già i nati negli anni settanta sono invischiati nel culto dell’Io, divinità pagana eretta nel tempio del Mercato dopo lo sfacelo delle Contestazioni incompiute, la Murgia non guarda all’ombelico rifatto dei suoi coetanei, ma fuori dalla finestra. “Non sapendo quando verrà l’alba, io spalanco ogni porta”, scriveva la Dickinson: forse davvero ci vuole uno sguardo femminile, un pensiero femminile, una intuizione della parte femminile di ciascuno di noi, per rivedere la cura per ciò che è Comune.
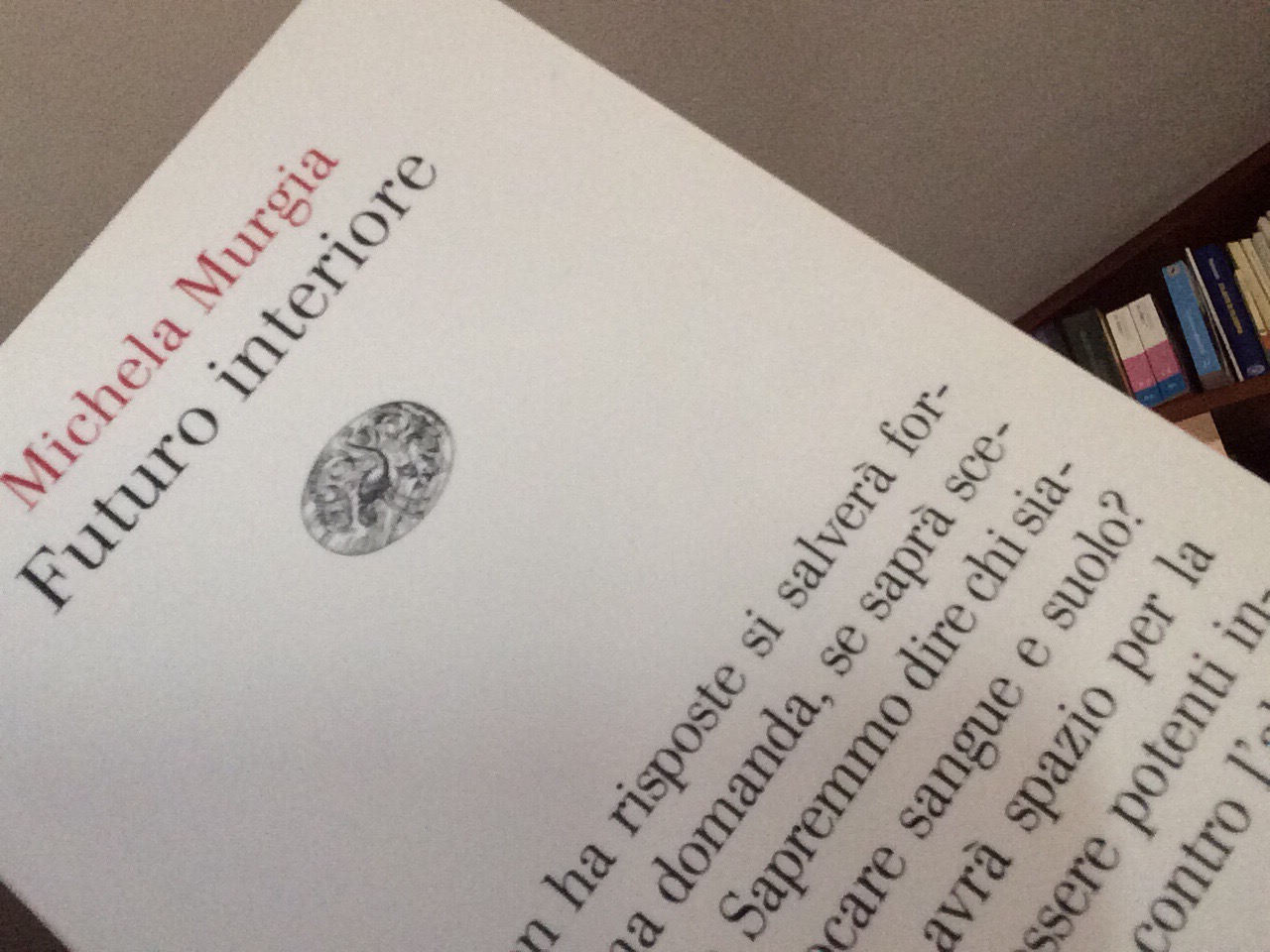
Un libercolo veloce, come generalmente le Vele einaudiane, propone argomentazioni serie e non scontate. La prima: pensare una cittadinanza libera dal giogo (e dal gioco al massacro) delle identità , nella quale si sveli la menzogna della cosiddetta integrazione che maschera una assimilazione vuota e cieca – la tolleranza già denunciata da Pasolini. In una Europa in cui le merci hanno libero passaggio ovunque e le persone invece debbano essere filtrate per non rovinare equilibri demografici e politici – è una sorta di imperialismo al contrario -, ius sanguinis e ius soli sono categorie obsolete. Esistono tuttavia “stati in gestazione” che stanno elaborando percorsi di autodeterminazione: sono esperienze con una storia reale (Catalogna, Transnistria, Scozia, Sardegna…), in cui cioè l’appartenenza non viene inventata, come nel caso della razza Piave. La strada suggerita è quella percorsa dal Canada, in cui centrale appare il coinvolgimento in una comunità affinché essa possa essere scelta. Tra il suolo e il sangue si situa dunque un progressivo movimento di deliberazione, che non può che partire dalle aule scolastiche.
Il secondo ragionamento riguarda gli spazi urbani, la loro bellezza e capacità inclusiva/democratica. Trovo interessante la necessità di rammentare come la bellezza di cui si dice abitata l’Italia sia per lo più nata in regimi abitati da profonda ingiustizia sociale, siano essi monarchici, curiali o dittatoriali. Al contrario, poi, la Repubblica non ha prodotto luoghi belli, adatti alla convivenza, ma quartieri dormitorio destinati ad essere sempre e comunque periferia. Possibile una via di mezzo? Possibile un ritorno alla piazza che non sia solo “del mercato”, ma che costituisca un luogo disordinato, abitato da diversità etniche e generazionali che convivono? La Murgia porta due esempi concreti, vivi. E mi viene in mente tutto il lavoro sotterraneo di Marianella Sclavi.
Il terzo passaggio riguarda il potere. È immaginabile senza una gerarchia? E una gerarchia senza violenza, tacita o agita che sia? Michela Murgia suggerisce come la storia delle donne contenga esempi di gestione non violenta del potere, perché storia di emarginazione e di alleanza tra emarginati. Mi viene in mente David Maria Turoldo, a colloquio con don Lorenzo Milani: concepisco la gerarchia come paternità . E, insieme, la lezione di Socrate: uomo buono è colui che obbedisce a sé stesso e a chi ritiene degno di comando. I padri e un filosofo – pur attento al femminile: questa via nuova al potere non è questione di sole donne. E gli esempi portati nel testicciolo lo confermano. Si tratta piuttosto di rinunciare ad una visione genitale del potere, una potenza inseminatrice che si gioca sul presunto carisma e sulla Soluzione continua, calata dall’alto. Qualunque processo partecipativo, compresa la Rete, deve riscoprire la pazienza, questa sì femminile, del lento coinvolgimento.