Segue da QUI.
8. La giovinezza in guerra
Le pagine di Giovanni Comisso, scrittore trevigiano, in particolare quelle tratte da Giorni di guerra, pubblicato nel 1930, ci consentono di leggere un ulteriore aspetto della guerra. Tra gli altri, è il polemologo Gaston Bouthoul a redigere una lettura psicologica e sociologica della guerra, a partire proprio dall’analisi della Grande Guerra.
Una delle principali caratteristiche della guerra, ci ricorda Silvio Lanaro nel suo Patria, citando il sociologo francese, è la «trasformazione istantanea del modo di pensare di tutti gli attori sociali, così come nel cambiamento repentino delle prescrizioni e delle interdizioni etiche» (p. 59 e poi p. 61 proprio su Comisso). Non si tratta solo della ovvia sospensione del comandamento del “non uccidere”, che in tempi di pace distingue l’assassino dall’innocente. La guerra è espressione di vitalità giovanile, di forza fisica, persino di gioco, per quanto mortale. Nel suo essere condizione di extra-ordinarietà , la guerra è assimilabile ad una sorta di assurda vacanza, un tempo liberato dai doveri borghesi, dal tempo della produttività capitalista. La guerra è un drammatico carnevale, in cui lo spazio ludico non raramente si tramuta in un inferno di follia.
Nel brano che segue, Comisso racconta come la guerra sia persino naturale occasione per “rubare l’amore” alle prostitute adibite al servizio della truppa.
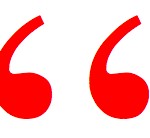 La casa spuntò bianca e isolata con i suoi tre piani e subito ci diede un grande battito al cuore. L’orto antistante era stato in parte ridotto a pollaio e scorgemmo nel recinto di rete metallica grasse galline che venivano nutrite con abbondanza da una vecchia. L’ingresso era pieno di soldati, molti scesi dalle trincee con il vestito pieno di croste di terra rossa. Il loro sguardo aveva un’espressione implorante e i più giovani aridi e barbuti sembravano invecchiati dalla vita di trincea come da un vizio precoce. Sentivo un continuo gorgogliare di acqua e mi accorsi che questo avveniva nei tubi esterni che partivano dalle varie stanze e a ogni gorgoglio di acqua corrispondeva la voce di una donna dall’alto delle scale: «Avanti a chi tocca, su da bravi ragazzi». I soldati stavano in fila per le scale, addossati contro al muro per lasciare spazio verso la balaustra agli altri che scendevano. Scendevano a testa china guardando dove posavano i piedi come avessero perduto l’abitudine di scendere i gradini di una casa. Le mani annerite e magre uscivano come sterpi dalle maniche consunte, le cinghie delle giberne solcavano le spalle ossute, le labbra secche tremavano: parevano confusi come per avere compiuto qualcosa di proibito o qualcosa a cui non si sentivano destinati. Quella donna che avevano potuto avere, era apparsa come un essere tanto diverso da loro, più pulita, meglio nutrita e con vesti che davano godimento solo a guardare. La fila di soldati si formava da un’attigua sala d’aspetto dove io e il mio amico passammo in attesa del nostro turno. In questa sala i soldati avevano un contegno più allegro, si facevano maneschi tra loro, si pizzicavano, qualcuno metteva a un altro la mano in mezzo alle gambe dicendo:«Vediamo se l’hai ancora». Ridevano e si abbracciavano e altri si divertivano a scrivere sui muri imbiancati di fresco il proprio nome e cognome con i numeri del reggimento e della compagnia. Altri vi facevano grandi disegni osceni o informi figure di donne nude. Un avviso inchiodato alla parete conteneva alcune norme d’igiene. «Il coito sia breve»: incominciava. Ogni tanto la voce della donna ripeteva l’ordine di avanzare e la fila si spostava di un passo. Tutti guardavano chi scendeva come per spiargli sul volto quanto si fosse goduto. (…)
La casa spuntò bianca e isolata con i suoi tre piani e subito ci diede un grande battito al cuore. L’orto antistante era stato in parte ridotto a pollaio e scorgemmo nel recinto di rete metallica grasse galline che venivano nutrite con abbondanza da una vecchia. L’ingresso era pieno di soldati, molti scesi dalle trincee con il vestito pieno di croste di terra rossa. Il loro sguardo aveva un’espressione implorante e i più giovani aridi e barbuti sembravano invecchiati dalla vita di trincea come da un vizio precoce. Sentivo un continuo gorgogliare di acqua e mi accorsi che questo avveniva nei tubi esterni che partivano dalle varie stanze e a ogni gorgoglio di acqua corrispondeva la voce di una donna dall’alto delle scale: «Avanti a chi tocca, su da bravi ragazzi». I soldati stavano in fila per le scale, addossati contro al muro per lasciare spazio verso la balaustra agli altri che scendevano. Scendevano a testa china guardando dove posavano i piedi come avessero perduto l’abitudine di scendere i gradini di una casa. Le mani annerite e magre uscivano come sterpi dalle maniche consunte, le cinghie delle giberne solcavano le spalle ossute, le labbra secche tremavano: parevano confusi come per avere compiuto qualcosa di proibito o qualcosa a cui non si sentivano destinati. Quella donna che avevano potuto avere, era apparsa come un essere tanto diverso da loro, più pulita, meglio nutrita e con vesti che davano godimento solo a guardare. La fila di soldati si formava da un’attigua sala d’aspetto dove io e il mio amico passammo in attesa del nostro turno. In questa sala i soldati avevano un contegno più allegro, si facevano maneschi tra loro, si pizzicavano, qualcuno metteva a un altro la mano in mezzo alle gambe dicendo:«Vediamo se l’hai ancora». Ridevano e si abbracciavano e altri si divertivano a scrivere sui muri imbiancati di fresco il proprio nome e cognome con i numeri del reggimento e della compagnia. Altri vi facevano grandi disegni osceni o informi figure di donne nude. Un avviso inchiodato alla parete conteneva alcune norme d’igiene. «Il coito sia breve»: incominciava. Ogni tanto la voce della donna ripeteva l’ordine di avanzare e la fila si spostava di un passo. Tutti guardavano chi scendeva come per spiargli sul volto quanto si fosse goduto. (…)
Una porta si aperse, intravidi una donna seminuda e un soldato uscì assestandosi le giberne. Quegli che mi precedeva gli chiese se si poteva levarsi le scarpe: gli rispose seriamente che appena si poteva togliersi le giberne per non rovinarle la pelle e pareva irritato. Toccò il suo turno, la donna spavalda gli presentò una marchetta che egli subito fece atto di prendere, ma ella gli impose di pagare e allora dal suo portamonete trasse il denaro: «Ancora, ancora, svelto», gli diceva la donna. «Non te l’hanno detto che si pagano tre lire?». Il soldato stentava a trovare le monete, pareva che in mezzo vi tenesse medagliette di santi. La donna era impaziente. «Ma, sacramento, siete proprio bambini. Non sapete neanche contare.» E presa l’ultima moneta lo spinse verso la porta semiaperta. Un’altra porta si aperse, toccava il mio turno, ne uscì un soldato biondo e roseo con il berretto sbandato sul capo, ci guardammo: «Com’è?» gli chiesi. «Bona assaie», mi rispose in napoletano e l’ultima parola gli si travolse stonata. La donna dopo avere gridato il solito richiamo giù per le scale, mi si rivolse violenta. «Su, in camera.» E datami la marchetta mi sospinse, senza lasciarmi il tempo di rivolgere lo sguardo al mio amico che aveva lasciato di tenere la sua mano infilata alla mia cintura”.
[Giovanni Comisso. Giorni di guerra, Longanesi 1960, pp. 73-77]
E Lussu, ancora (Un anno sull’Altipiano):
«I gruppi si rianimarono quando un graduato ritornò dal vivandiere con i fiaschi del vino e col tabacco. Egli aveva speso tutte le venti lire. In guerra, non si pensa al domani» (p. 23).
La guerra infatti semplifica il tempo, lo sospende: ha quasi la funzione che l’individuo riserva all’alcol, in particolare al cognac, lo strumento per isolarsi dall’assurdo:
«Io mi difendo bevendo. Altrimenti, sarei già al manicomio. Contro le scelleratezze del mondo, un uomo onesto si difende bevendo. E’ da oltre un anno che faccio la guerra, un po’ su tutti i fronti, e finora non ho visto in faccia un solo austriaco. Eppure ci uccidiamo a vicenda, tutti i giorni. Uccidersi senza conoscersi, senza neppure vedersi! E’ orribile! E’ per questo che ci ubriachiamo tutti, da una parte e dall’altra. Ha mai ucciso nessuno lei? Lei, personalmente, con le sue mani?» (p. 37).
Vengono in mente gli alpini ubriachi di ritorno dal Don, nel Gennaio del ’43, descritti da Rigoni Stern.
9. Memorie
Alla fine il racconto, la narrazione. E’ l’ultimo esorcismo contro la mancanza di senso, l’ultimo esercizio per sentirsi perdonati per il fatto di esser tornati, e ancora una volta per esser riconosciuti per quel sacrificio non cercato. Chi può capire un’esperienza che ti ha scavato nell’animo e nel corpo? Nonostante le note di allegria e tenerezza, queste testimonianze nascondono il dramma.
10. Armiamoci e partite
E chi resta a casa?
Tralasciamo ora le vicende di migliaia e migliaia di donne e figlie (e figli), in attesa di notizie, cartoline, decreti di morte o di scomparsa.
L’opinione pubblica, parte della quale era stata interventista, inizia a rivedere il proprio giudizio, in Italia e altrove, lungo il 1917. Accelerano quindi le strategie (da parte dei governi di unità nazionale per compattare il cosiddetto fronte interno, da un lato con la repressione (specie in Germania e Russia), dall’altro
> condizionando la stampa
> con immagini e slogan di propaganda
> invitando ad arruolarsi o a sostenere economicamente le operazioni con titoli di debito pubblico.
[11. Poscritto #1]
Attorno al Centenario della Grande Guerra si sono naturalmente moltiplicate le pubblicazioni, sia tecniche che di fiction.
Riporto qui una recensione, che è anche un’occasione per pensare a come stare di fronte ai 100 anni, del libro di Paolo Malaguti, Prima dell’alba.
Come ricordare questo 4 novembre? E poi, perché farne memoria? Tra pochi giorni le iniziative del centenario taceranno. Il libro di Paolo Malaguti (Prima dell’alba, Neri Pozza editore) costituisce un’ottima occasione per capire che cosa ricordare, per avvertire l’ingombro del passato.
Il peso della moneta estratta dal panciotto di Graziani è lo stesso, insostenibile, di quella elargita dal generale Leone descritto da Emilio Lussu. In entrambi i casi, l’assordante autoreferenzialità dell’ufficiale rimbomba e riempie lo spazio di senso, come una sirena d’allarme che impedisca per qualche istante qualsiasi altra percezione. L’imponenza verticale delle stellette si ripiega magnanima su se medesima, per lambire, illuminandolo con la propria dignità, il fante miserello. Probabilmente contadino ignorante. In entrambi i casi, la distanza tra le due persone si misura invece sull’effettiva esperienza della guerra, sul tempo di terrore «buttato accanto ad un compagno massacrato». E’ anche separazione generazionale – cinquantenni contro ventenni – ma non meramente anagrafica però, giacché quelli più anziani hanno deciso deliberatamente di mandare a morte quelli più giovani. Malaguti individua la figura del mediatore nel Vecio, uomo della truppa della prima ora: nel 1917 è ormai veterano e sa osservare e sostenere l’assurdo, consapevole che non è possibile spiegare tutto ai ragazzini appena arrivati. La meglio gioventù del Carso, del Grappa, del Piave ha ricevuto e riceve tributi e riconoscimenti da cento anni esatti, nella fiction delle commemorazioni. V’è da chiedersi di che cosa si possa far memoria, se delle storie ripetute nelle case, dai figli e dai figli dei figli, narrazioni talvolta attese per anni, oppure della Storia Ufficiale, mai completa, troppo poco studiata, e in fin dei conti sempre a rischio di affogare i singoli nella complessità degli eventi.
Come Lussu, anche Paolo Malaguti scrive per denunciare, per riportare al centro della riflessione quei nomi, di uomini e anche di donne, che nel primo conflitto bellico mondiale hanno trovato la svolta o la fine della propria vita. La denuncia è lanciata in faccia alla retorica di regime, per Lussu in senso stretto, onde smitizzare lo spirito di Vittorio Veneto e sottrarlo alla strumentalizzazione fascista. Malaguti vive nei nostri complicati tempi di liberal-democrazia, ma egualmente intende marcare la distanza tra la singola esistenza interrotta dalla follia dell’astratto dovere militare e lo Stato, che essa giustifica, capace solo di cibarsene, Leviatano, e di autocelebrarsi. E così, la vicenda di “Prima dell’alba” contiene sì la narrazione dei fatti storici che vanno dal ripiegamento di Caporetto all’armistizio, ma soprattutto ospita decine e decine di nomi divorati da quella follia medesima, e date e luoghi e sentenze di morte.
Che lo scrittore faccia l’insegnante, lo si avverte a pelle, perché se l’intento è generosamente ed efficacemente antiretorico, talvolta emerge l’esigenza didattica di spiegare nel dettaglio le dinamiche della vita di trincea, dei movimenti di ritirata, dello strazio quotidiano dei reduci. Il romanzo diventa quindi un testo storico, per precisione e conoscenze, che sa però mantenere viva una certa curiosità sfruttando l’enigma noir della morte, nel 1931, del generale Andrea Graziani, nominato da Cadorna “Ispettore generale del movimento di sgombero” il 2 novembre 1917 in seguito alla disfatta di Caporetto, responsabile dunque del mantenimento della disciplina nella fase di ricostituzione del fronte. La sua vicenda, attraverso le indagini dell’ispettore Ottaviano Malossi della Questura di Firenze, si intreccia a quella del Vecio, testimone oculare della crudeltà di Graziani e poi reduce allo sbando.
La lettura di “Prima dell’alba” può essere superflua per chi sia già esperto delle vicende della Grande Guerra. E’ invece utilissima per chi voglia accostarsene, sempre che questo lungo centenario non abbia prodotto, come spesso accade ai ragazzi a scuola con le ricorrenze più o meno subite, quella sorta di noia per qualcosa che appare scontato, e non lo è. Qualcosa in particolare non è affatto ovvio, rimane sconosciuto, e potrebbe costituire davvero una celebrazione rispettosa di quei loro coetanei di un secolo fa: i loro nomi e cognomi. In ogni paese, grande o piccolo, del Veneto esiste un monumento ai Caduti: è lì, da decenni, parte del paesaggio urbano, elemento stabile della piazza, talmente immobile da risultare ignorabile. Si tratta allora, non solo per il 4 novembre 2018, di fermarsi qualche istante di fronte a quella lapide o statua, e mandare a memoria uno o due nomi, immaginando il viso, la voce delle persone evocate. Un piccolo rito personale, non pubblico, rivolto a chi non è più.

